Cool Ghouls – Animal Races (2016)
Proprio vero che a volte il salto di qualità richiede la giusta spinta.
Prendete i Cool Ghouls, uno dei quartetti più promettenti nella sempre vivacissima scena rock underground di San Francisco, fino a ieri etichettabile come interessante ma non certo tra gli indispensabili della categoria. A prefigurare una svolta, nel loro caso, è stata la scelta di affidare la produzione della loro opera terza – questo “Animal Races” – a uno dei padrini della Bay Area, Kelley Stoltz, che ha registrato il disco direttamente nel suo Electric Duck studio coadiuvato da quel Mikey Young (australiano, uno dei Total Control) che aveva già lavorato con loro per il notevole predecessore, “A Swirling Fire Burning Through The Rye”, oltreché con Twerps e Royal Headache. Completa il quadro dei debiti significativi l’artwork curato dall’amica Shannon Shaw, altra promessa ascesa al rango degli imprescindibili in un paio di mosse appena.
Dalle sonorità più sporche e psichedeliche à-la Black Lips, di fatto un’attualizzazione dell’epopea Nuggets, i Cool Ghouls hanno operato un progressivo raffinamento verso un power-pop a tutto tondo, baldanzoso e fragrante, alla maniera di Gentleman Jesse: vocalismi e chitarre jangle fedeli al canone byrdsiano, basso puntiglioso in primo piano, linee pulite e scorrevoli improntate a un placido revival tardi sixties davvero sicuro del fatto suo.
Il singolo “Sundial” rende spudorata la marcatura Paisley Underground à-la Rain Parade e davvero incanta. Se la conclusiva “Spectator” ricorda le cose meravigliose di cui erano capaci Matthew Caws e Daniel Lorca quando si chiamavano ancora The Cost Of Living, in “Just Like Me” l’ordito avvolgente delle chitarre apre invece all’incisività di una performance vocale completa, estrosa nel ricorso ad armonizzazioni Rem-iane e abile a edificare con perizia impalcature corali di tutto riguardo, mentre la vampa elettrica che chiude sublima questo esercizio da veri virtuosi (i giovani Peter Buck e Mike Mills sono un po’ i convitati di pietra, qui e in “Never You Mind”) negando in partenza, e senza appelli, qualsivoglia tentazione manierista.
Al di là della pedissequa riproposizione di uno stile, si apprezzano anche un songwriting particolarmente incoraggiante e un’innata propensione alla melodia che tende al prodigioso, qualità che non possono essere derubricate chiamando in causa solo una diligente applicazione di codici espressivi, pure innegabile, poiché si impongono piuttosto come la fonte primaria di una vera delizia per le orecchie (non necessariamente dei soli passatisti intransigenti).
Altrove il richiamo a un’ideale macchina del tempo si fa esplicito, esaltato dall’immersione in una fotografia sovraesposta, riverberatissima, un consesso di Rickenbacker chiamate a macinare terreno su terreno con disinvoltura impressionante, nonché un affaccio sbalorditivo su un passato musicale ormai prossimo alla pura mitologia. E in queste esplorazioni c’è grande dolcezza pure al di là della malinconia tipica degli sguardi beatamente orientati al disincanto, come accade in “When You Were Gone”. Ne esce una prova oggi etichettabile per approssimazione come Americana – eloquente in passaggi più certosini e articolati di stampo quasi alt-country (“The Man”) che incantano grazie alla superba pedal steel di Tom Heyman (già collaboratore di Hiss Golden Messenger e Girls) e richiamano alla mente i primi, giocondi Jayhawks – anche se le radici in questo caso affondano più che altro in un terreno sottratto ai consueti canoni temporali, secondo una prospettiva a parte, sospesa, congelata in un eterno idilliaco presente.
Tutto il gioco si regge su una proverbiale semplicità di fondo che, a dispetto di quanto si potrebbe credere dal non meno fruttuoso riciclo di progetti più sfacciatamente barocchi, tradisce una solidità d’impianto senza eguali. Una così convincente opera di rilancio stilistico non era forse facilmente preventivabile, ma l’affidabilità palesata oggi dai Cool Ghouls non dovrebbe lasciare ombre o margini di dubbio sulla bontà di un album che convince da qualunque prospettiva lo si affronti. Anche gli affezionati della primissima ora troveranno comunque opportuna soddisfazione da quel paio di episodi che operano in alleggerimento: una “Days” che lascia le deleghe a un pianoforte smaliziato (e ricorda il brano omonimo dei Kinks), e quella “Brown Bag” che si aggiudica a mani basse la palma per il titolo più schietto, rumoroso e inesorabile del lotto, una mosca bianca d’estrazione ruvidamente garagista, parente stretta di quelle meno estemporanee che il quartetto californiano aveva liberato nelle precedenti due uscite.
Tutto più che rimarchevole, insomma. A questo punto il nome Cool Ghouls entra di diritto tra le teste di serie della categoria garage-revival.
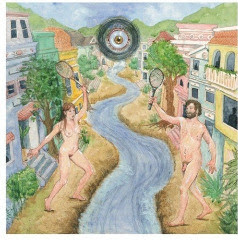
Commenti
Posta un commento